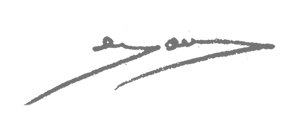Il tempo di Joan Crous non è tempo e non ha un nome.
di Beatrice Busacroli
Il tempo di Joan Crous non è tempo e non ha nome.
Troppe le citazioni, troppi gli spaesamenti che facilmente si possono chiamare in causa per definire un luogo, una stagione, un inizio o una fine, una sorta di catastrofe, o una sorta di reinizio.
Non chiamerei in causa neppure l’archeologia, che Crous sembra soltanto e soltanto casualmente sfiorare. Anche se da ogni angolo, da ogni visuale, da ogni minimo sguardo tutto sembrerebbe voler invocare l’approccio a una sorta di archeologia del futuro o il fantasma di un passato, il suo stile è unicamente frutto di una straordinaria tecnica che incide sì il tempo e, come ogni opera d’arte, sempre lascia una traccia e non lascia il mondo uguale a prima. Non vorrei tuttavia banalizzare un lavoro come il suo con la semplice ricerca di uno spazio inventato nel centro di una possibilità che contempli l’universo intero dell’arte, non vorrei farlo diventare una specie di gioco museale destinato ai bambini che devono studiare gli antichi.
L’intelligenza di Crous sta proprio in questa sua libertà. Non si fa definire con luoghi, persone, accostamenti. Se lo è inventato lui e tutto quel che significa è soltanto frutto di una intelligenza velocissima e lucida che attraversa le epoche deridendole, in un certo senso, traendo insegnamenti e vicinanze, ma sempre standone fuori.
I romani non usavano le flûtes, né le forchette. Il Bevitore di Arturo Martini sbava a terra imitando uno dei moribondi della furia del vulcano, ne ha in corpo perfino la porosità della pelle.
Mi piace pensare a Crous come a un Martini. Senza soggiogarlo a una didascalica “imitazione”.
Si chiedeva Henry Focillon”: “In quest’insieme così diverso e così ben connesso, dov’è l’uomo?”
“Oppure, riparati dietro un vocabolario, non abbiamo fatto altro che della psicologia in immagini? Non è tempo di risalire alla fonte? Queste forme che vivono nello spazio e nella materia, non vivono, innanzitutto, nello spirito? O piuttosto non vivono veramente, e persino unicamente, nello spirito, e la loro attività esteriore non è altro che la traccia di un processo interno?”. (1934)
“Sì, le forme che vivono nello spazio e nella materia vivono nello spirito”.
Parole fondamentali, nella storia dell’arte, tratte da un capitolo che si chiama “Le forme dello spirito”.
Penso che il sogno senza tempo di Crous abbia un rapporto reale con le parole di questo storico dell’arte unico, che scandagliò i perché dell’arte senza volere a tutti i costi “compilare” una storia dell’arte.
“L’artista”, scrive ancora Focillon “fa risalire in superficie, all’ aria libera (….) una conoscenza automatica e logora, sepolta nel nostro essere. L’artista prolunga quel privilegio che è, nell’infanzia, la curiosità, estendendolo ben oltre i limiti di tale età della vita. Tocca, tasta, valuta il peso, misura lo spazio, modella la fluidità dell’arte del prefigurarvi la forma….”.
L’ opera di Joan Crous è troppo libera per entrare nelle sale di un museo. L’opera di Joan Crous è un breve sogno che dà all’istante la novità dell’eterno, ma non perché debba necessariamente somigliare a qualcos’altro.
Tutto decade e muore, tutto si logora e finisce, ma il Bevitore di Martini cercava l’acqua dopo duemila anni.
Per questo Crous è un autore di un altro tempo, dove i tempi sono raggelati e racchiusi in una forma che non è la vetrina di un museo.
Le sue tavole splendono, i suoi bicchieri rotti rilucono, certi accostamenti sembrano sfidare ogni interpretazione.
Quel che stupisce è l’assemblaggio finale delle sue installazioni, che non sono finte archeologie, né spaventose premonizioni di un futuro prossimo, ma l’esercizio di una bravura tecnica e concettuale che cela in sé il suo segreto e va soltanto guardata, non spiegata.
Contemplata, direi.